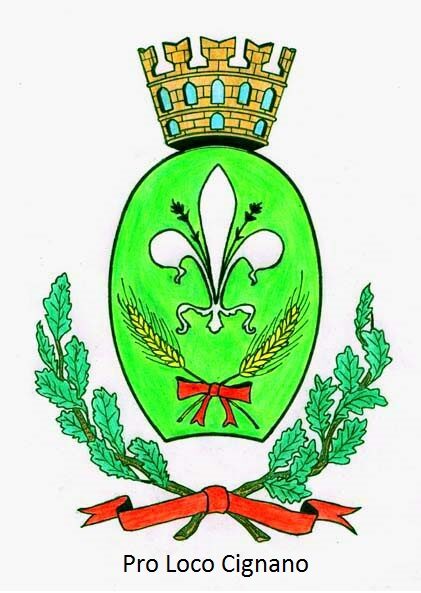La cascina “Torcol”, che oggi vediamo, non è l’antica costruzione che per secoli ha svettato in questo luogo. L’attuale edificio è stato costruito nel 1912, sulle storiche fondazioni e sorge costeggiando la Roggia Cignana, lungo la strada che da Cignano, conduceva al borgo della Mirandola e poi a Dello. La primitiva costruzione molto probabilmente risale al periodo dello scavo della roggia (sec. XIV-XV). I progettisti/costruttori dei canali, in funzione della pendenza del territorio circostante, tenevano un opportuno livello il vaso in modo da ottenere a distanze opportune dei dislivelli dove far fare all’acqua dei salti ed usarne l’energia, per muovere i macchinari degli opifici. A quell’epoca, i mulini erano paragonabili alle attuali industrie, indispensabili per molte lavorazioni che variavano in funzione delle coltivazioni locali e che davano ai proprietari notevoli ritorni economici. Le prime indicazioni della presenza di un mulino in questo luogo, si iniziano a trovare nei catasti.
Nel Catastico Veneto del 1641, alla partita del Comune di Cignano, l’edificio così viene descritto:
«Due edifici nella seriola Cignana in contrada della Mirandola, uno per far l’olio di linosa, et l’altro per pestar il riso, d’una rota per uno, confina da monte detta seriola, a mattina strada a sera, et mezzodì Livio Avogadro, estimata lire 3980. Si batte il sesto per l’edificio dell’olio et riso».
Analoga descrizione nella revisione del catastico del 1689. Come si evince dalla descrizione catastale, l’edificio possedeva due ruote distinte, tante quante sono le canalette ancora esistenti. Ogni ruota era collegata ad un macchinario per la specifica lavorazione. Una muoveva il pistariso che con il movimento alternativo dei pali in legno serviva per la brillatura del riso. L’esistenza di questa lavorazione era giustificata dal fatto che fino ai primi anni del 1800, nei campi ai lati della Roggia Manerbia vi erano campi seminati a riso, in questo modo era giustificata la presenza del pistariso. Le risaie, producevano un buon reddito ai proprietari (nobili non residenti in paese), un minimo di sostegno alle mondine e alle loro famiglie e gratis per tutto il popolo c’era la malaria. Solo dopo molti anni di petizioni e proteste delle popolazioni di Faverzano e Cignano, la coltura venne eliminata. Del macchinario ivi presente non vi è più traccia. Il basamento con i buchi dove si metteva il riso da brillare, poteva essere in legno o in pietra. Una pietra adibita a basamento per pistariso si può vedere a Scorzarolo, ed è oggi utilizzata come banchina di un ponte. Se il basamento fosse stato in pietra potrebbe trovarsi da qualche parte disperso sul territorio. Eliminata la coltivazione di riso, venne meno l’utilità del pistariso. La seconda lavorazione, quella del lino prevedeva la presenza di un torchio, anch’esso mosso dalla forza dell’acqua della Cignana, che dalla spremitura dei semi permetteva di ottenere l’olio di linosa e dopo la macerazione dei gambi le fibre per tessere. In diversi paesi del Territorio si trovavano simili impianti (l’enciclopedia bresciana elenca: Leno, Onzato, Oriano, Pontevico Pralboino, San Gervasio, Torbole, Villachiara, Villanuova). L’opificio rimase in attività fino agli inizi del XIX secolo, quando, venendo meno il ritorno economico per la lavorazione del riso, nessuno più lo prese in affitto. Lasciato vuoto ed abbandonato nel giro di pochi anni crollò e venne smontato pezzo per pezzo: i mattoni, il legname, i coppi, tutto quanto possibile venne recuperato. Nel catasto napoleonico del 1805 al mappale 43, il mulino è ancora intestato alla comunità di Cignano e la descrizione recita: «Torchio della Mirandola: pila da riso e torchio d’oglio». Nel catasto austriaco del 1834 il mappale 43 reca la dicitura di: «zerbo», incolto. Nel 1852 il Comune di Cignano vendette la pezza di terra a Giovanni Renica q. Giacomo. Nel 1870 passò in proprietà a Laura Co’ q. Giuseppe. Nel 1879 lo troviamo intestato a Francesco Tirelli q. Giovanni, che nel 1883, lo passò alla sorella Lucia e 10 anni dopo al fratello Francesco. All’inizio del secolo il proprietario era Ludovico Garbottini, che nel 1907 lo vendette a Orazio Pancera q. Giuseppe. Viste le dimensioni dell’edificio, oltre alle due lavorazioni già descritte è probabile la presenza nello stesso immobile di uno o più torchi per torchiare le uve. Da tempo immemore, nel Territorio bresciano molti erano i campi che ospitavano anche delle viti, coltivate in filari promiscuamente con altri foraggi. A Cignano, nel catasto Austriaco del 1834 erano presenti 81 campi, divisi fra: (aratorio vitato adacquatorio, adacquatorio vitato, campo vitato e orto vitato) per circa 575 piò bresciani, numero salito a 87 campi per una superficie di circa 580 piò, descritti nel catasto Lombardo-Veneto del 1852. Durante il periodo della vendemmia i torchi erano indispensabili per estrarre fino all’ultima goccia di vino dalle uve raccolte. Bere l’acqua dei fossi o dei pozzi superficiali spesso era fonte di malattie e quindi il vino era bevanda indispensabile. Esempi di questi torchi si trovano in tutto il continente europeo nei luoghi ove era praticata la coltivazione della vite. Un torchio maestoso e integro si può ammirare alla Certosa di Pavia, un rifacimento recente esiste in Gussago ed è collocato al centro di una rotonda stradale, ma molti altri, ormai in disuso, sono ancora visibili nelle nostre valli. Poi la coltivazione della vite nel nostro territorio ebbe un brusco stop verso la fine del XIX secolo in seguito alla diffusione della Filossera, un parassita che ha fatto morire gran parte delle piante di vite autoctone che non erano in grado di difendersi. Nel 1912, Orazio Pancera, costruì l’attuale edificio con l’intenzione di collocare una ruota idraulica che, durante l’inverno sfruttando il salto dell’acqua, avrebbe mosso i palmenti di un mulino. Incaricò l’ingegner Romeo Romano di Brescia, di stendere accurata relazione, che accompagnava il progetto stesso, ma l’istanza non ottenne l’autorizzazione dalla compartita e l’idea di ripristinare il mulino svanì. Da allora l’edificio è divenuto una civile abitazione. Molto probabilmente da qui arrivano i pietroni oggi visibili in piazza, che in epoca imprecisata furono recuperati e traslati per ornare l’ingresso del castello.